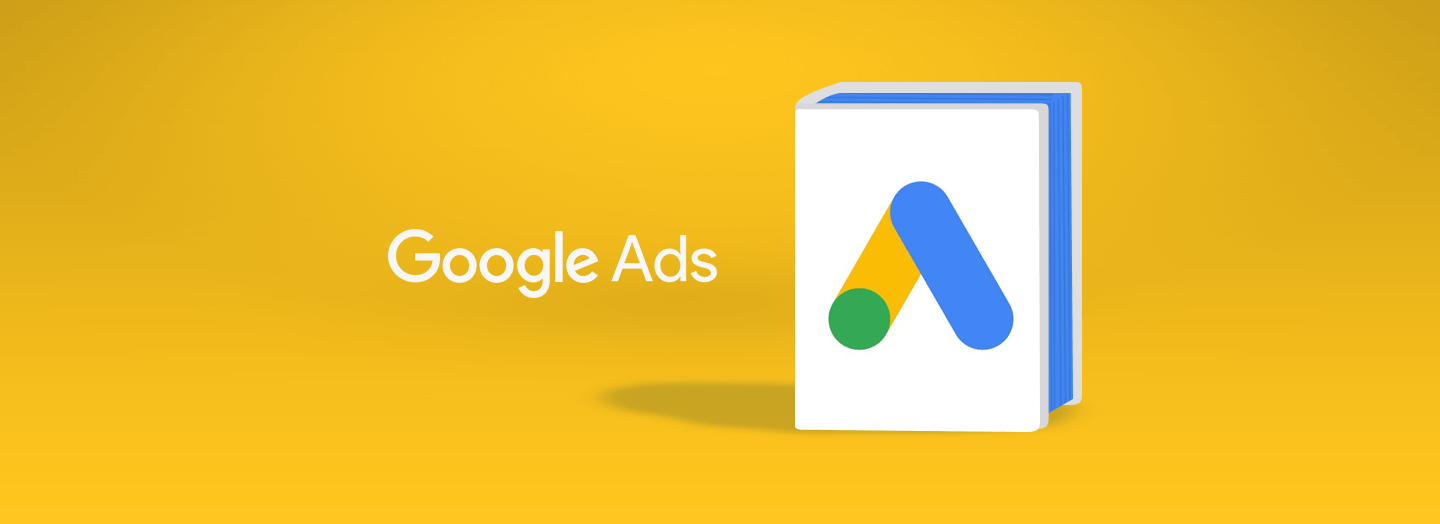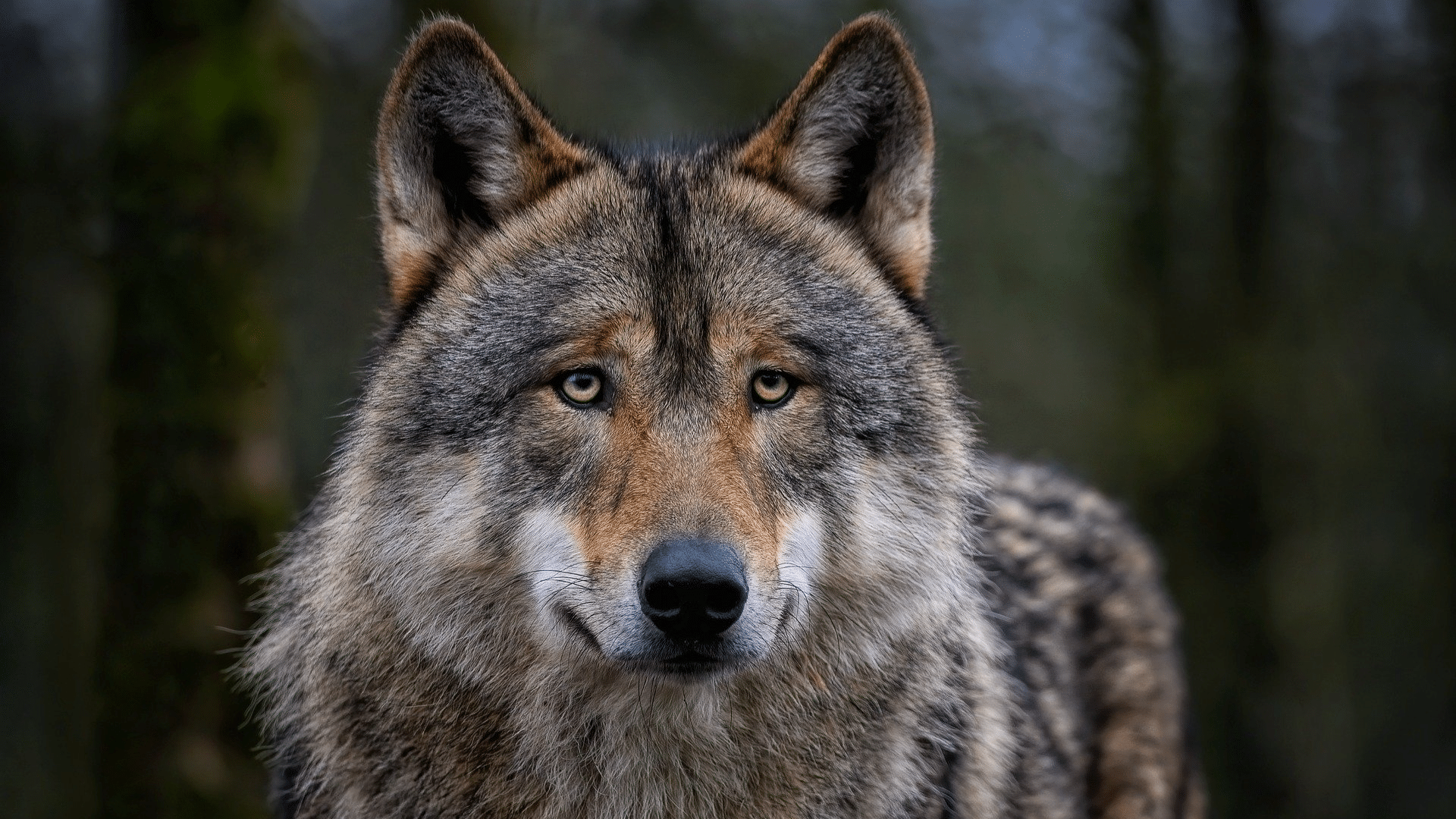- Ottobre 12, 2023
- 7:00 am
Gli accordi di Parigi e il destino delle Alpi senza neve. Intervista a Luca Mercalli
Con il riscaldamento globale le Alpi, e non solo, sono in pericolo. Con gli accordi di Parigi possiamo pensare di salvarle? Ne abbiamo parlato con il climatologo Luca Mercalli.

Se non applicheremo gli Accordi di Parigi sul clima, tra trent’anni le Alpi saranno senza più neve. Lo certifica un’analisi di quattro ricercatori italiani, pubblicata sulla rivista scientifica Nature Climate Change. Una minaccia per tutto il continente europeo, visto il ruolo chiave delle Alpi come riserve d’acqua per l’Europa e l’importanza dell’innevamento invernale per l’ambiente naturale, il turismo e l’economia. Perché c’entrano gli accordi parigini sul clima? Se si riuscisse a mantenere l’aumento della temperatura entro 1,5° C, cioè il limite su cui si è trovata la convergenza internazionale nel 2015, il 32 per cento delle stazioni sciistiche europee sarebbe comunque a rischio, ma con l’uso dell’innevamento artificiale questo rischio si ridurrebbe di quasi 20 punti percentuali. In Italia, il 69 per cento degli impianti sarebbe in difficoltà, ma con l’innevamento artificiale, questo numero si ridurrebbe al 17. Tuttavia, se la temperatura aumentasse ancora di 3°C rispetto all’era pre-industriale (la tendenza delle ultime due estati), tutte le stazioni sciistiche delle Alpi italiane sarebbero senza neve. Ma l’innevamento artificiale può essere una soluzione per la tutela economica e ambientale delle nostre montagne? Di questo e dello stato degli Accordi di Parigi abbiamo parlato con Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico italiano.
Le stime recenti hanno calcolato che anche rispettando le tempistiche e gli obiettivi di Parigi (massimo +1,5° C rispetto alle temperature del 2015) dovremo dire addio a molti ghiacciai e altrettante stazioni sciistiche, in special modo sulle Alpi. E se invece la tendenza dell’aumento odierno, pari a 3° C, andasse avanti?
Vale sempre la pena puntare al contenimento dell’aumento di temperatura perché, come dice Antonio Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite, ogni frazione di grado conta. Purtroppo, però i nostri ghiacciai sono condannati: Parigi sì o Parigi no, è solo questione di tempo. Forse resteranno solo due piccoli cappucci sulle vette del Monte Bianco e del Monte Rosa. Le Alpi perdono già oggi circa un metro e mezzo di ghiaccio all’anno in media, e gli ultimi due anni, il 2022 e il 2023, da soli hanno tolto sei, quasi sette metri di ghiaccio a causa delle temperature estive straordinariamente elevate. Anche se riuscissimo a contenere l’aumento di temperatura entro il grado e mezzo, massimo due gradi, per le nostre montagne si prolungherebbe soltanto l’agonia: entro questo limite i ghiacciai li perdiamo a fine secolo, se la temperatura aumenterà più rapidamente nel 2050 non ci sarà più nulla, ormai la loro sorte è segnata. Diverso il caso di altre catene montuose, dove una riduzione dell’aumento di temperatura può invece salvare la situazione. Penso all’Himalaya, ad alcuni ghiacciai dell’Alaska, alla Groenlandia, che è la zona di ghiacciai più critica perché un suo scioglimento può far aumentare il livello del mare, in caso di collasso totale.
Qual è lo stato di applicazione degli Accordi di Parigi?
Purtroppo abbiamo una grande burocrazia climatica. Gli accordi vengono aggiornati ogni anno alla famosa COP, la Conferenza delle Parti, che è arrivata alla 28° edizione di Dubai. Sarà tra un mesetto circa e porterà a progressi molto limitati. Sulla carta l’accordo di Parigi è operativo, ma vanno presi in esame i dati delle emissioni: se si considera l’ultimo anno completo, il 2022, si nota che sono al livello massimo nella storia dell’umanità. L’accordo di Parigi è stato firmato nel 2015, e allora viene da dire “Ma scusa, sono passati otto anni e abbiamo ancora aumentato?”. L’unico momento in cui le emissioni sono scese non è stato grazie all’accordo di Parigi, ma grazie ai lockdown: nel 2020 le emissioni globali sono scese del 6%, solo che poi dal 2021 hanno ripreso a salire ampiamente di nuovo, superandole, con il risultato che per ora non c’è nessun segnale di diminuzione. Poi, lo sappiamo, l’accordo di Parigi dice che dobbiamo arrivare a zero emissioni nette entro il 2050… mancano 26 anni, diciamo che speranza ce n’è, ma i fatti non ci aiutano a essere ottimisti. Anche Papa Francesco si è scagliato contro questa inerzia nella recentissima esortazione “Laudate Deum” che ha pubblicato il 4 ottobre. Papa Francesco dice proprio questo: “Sono passati otto anni, non abbiamo fatto niente, solo chiacchiere”.
Quanto hanno inciso sull’applicazione degli accordi di Parigi il lockdown e abbandono dell’accordo da parte degli Stati Uniti ai tempi di Donald Trump?
Quando si sono fatti i primi calcoli dell’anno 2020, si è visto che c’è stata la diminuzione del 6% delle emissioni. Sarebbe il trend che dovrebbe essere mantenuto tutti gli anni per rispettare l’accordo di Parigi, e invece subito dopo con le riaperture le emissioni sono riprese, anche più di prima: c’è stato il cosiddetto effetto rebound (rimbalzo, ndr). Sull’altro fronte, penso che l’uscita decisa Trump abbia avuto un impatto marginale perché non è durata abbastanza da causare una reale cambiamento di strategia degli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden poco dopo è rientrato, non penso che possiamo attribuire gli scarsi risultati a questa mossa. Anche con l’ex vice di Barack Obama, inoltre, non è che si stia procedendo con la velocità con la quale avremmo bisogno di andare avanti: questo vale per gli Stati Uniti, per la Cina e per l’Europa.
La mancata applicazione degli Accordi deriva da un problema di governance o da una mancata sensibilità della popolazione mondiale rispetto a questo tema?
Manca tutto. Se ci fosse soltanto la consapevolezza dei governanti su temi così vasti e complessi e mancasse il sostegno dei cittadini, sarebbe impopolare e difficile prendere decisioni dall’alto in questo senso. Sono necessarie, ma hanno anche bisogno del sostegno da parte delle masse. Purtroppo non siamo preparati né da una parte, né dall’altra, è un cane che si morde la coda: lo scarso consenso sul tema ambientale e climatico da parte delle masse fa sì che non sia un ambito che genera consenso e la politica si occuperà quindi di altri argomenti più comodi, più appaganti sul piano elettorale. Le istituzioni non sono spronate a occuparsi del problema perché ne ha più svantaggi che vantaggi e tutto questo porta allo stallo, al rallentamento. Dobbiamo fare passi avanti sia sull’aumento di efficacia della leadership, ma servono anche l’approvazione e il sostegno da parte delle masse.
Cosa si può fare dal punto di vista della governance internazionale del clima? Le Nazioni Unite fanno abbastanza?
Le Nazioni Unite da questo punto di vista sul clima fanno moltissimo, tengono in piedi le strutture di monitoraggio: non dimentichiamo che hanno in pancia l’organizzazione meteorologica mondiale, l’IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) e il programma ambientale UNEP, tre grandi strutture che tengono alta l’attenzione sul tema e si occupano di coordinare tutta la parte scientifica. Quando viene il momento di mettere in pratica soluzioni concrete, però, le Nazioni Unite non hanno alcun potere esecutivo e si limitano a suggerire, a proporre. Ci si blocca sulle volontà dei singoli Stati.
È giusto criminalizzare gli attivisti per il clima? Le loro azioni di protesta, talvolta estreme, a suo avviso, sono atti da condannare o si dovrebbe cercare di guardare quello che per cui protestano e non la protesta in sé?
Io sono per questa seconda visione. Le masse non hanno grande consapevolezza e consenso rispetto a questo tema, il che si riflette nella frustrazione delle giovani generazioni che sono minoritarie rispetto al resto della società, lo sono perfino all’interno della fascia studentesca. I toni radicali di gruppi come Ultima generazione ed Extinction Rebellion, ma anche Fridays for future, non sono altro che una reazione frustrata alla indifferenza del resto della società. Da un punto di vista concettuale appoggio e condivido la preoccupazione e la necessità di una reazione determinata. Poi, possiamo discutere sulle modalità di protesta. Forse occorre che facciano le loro valutazioni, dato che i metodi finora impiegati sono stati poco produttivi e hanno portato all’ostilità nei loro confronti da parte delle altre fasce della società. Si trovino mezzi più efficaci: ci vuole creatività anche nelle proteste.
ULTIME NOTIZIE